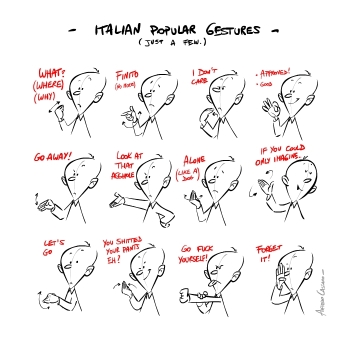Con lo sguardo ingenuo e attonito del marziano, o di chi da molto tempo si relaziona in una cultura del lavoro molto diversa, colgo l’occasione per fissare le cose che mi lasciano interdetta mentre mi riavvicino cauta al mio paese, e comincio a ripetere quello che nei prossimi mesi credo diverrà il mio mantra quotidiano: “una vita (dignitosa) in Italia è possibile…” Ed è solo l’inizio…
Mi dico che continuare a giocare la parte dello straniero basito in patria non sarà facile, ma è importante. È importante mantenere questo sguardo e comportarsi come se l’alternativa fosse la propria normalità (ora lo è!), spiazzando con le domande chi ti si rivolge pensando di avere l’unica verità tasca. Ora, non sto scoprendo nessuna verità, ma voglio solo metterla per un momento allo specchio.
Cercare lavoro
all’estero
Nei siti specializzati gli annunci si rivolgono a professionisti di tutti i livelli (dallo stagista al manager) e in tutti i settori, inclusi testate giornalistiche, enti statali e para-statali, e organizzazioni internazionali come Nazioni Unite o le istituzioni europee. Quindi per cercare lavoro in una città, uno guarda gli annunci e manda il CV dove più gli interessa. I soldi non sono un tabù, e spesso la forbice relativa all’eventuale proposta economica è chiaramente indicata, perché elemento decisivo nella preselezione dei candidati secondo esperienza e talento.
in Italia
Nei siti specializzati gli annunci si rivolgono prettamente a ruoli tecnici o iper-specialistici (ingegneri, software developer, esperti di chimica industriale) o executive nel settore vendite o comunicazione, ovviamente solo nel mondo del privato. Tutto il resto affonda in un fitto mistero…e uno non sa nemmeno dove mandarlo il CV. Di soldi poi, per pudicizia, non si parla; in Italia, si lavora per passione!
I siti web di aziende ed enti
all’estero
Non solo sono tutti rigorosamente dotati di una sezione “jobs” in cui pubblicare – e aggiornare – le vacancies; ma la maggior parte delle volte riportano nome, responsabilità e indirizzo email dello staff. A volte anche la foto. Essere presenti, avere visibilità, è visto come un’opportunità.
in Italia
Se la sezione “jobs” resta un’utopia, quella contatti è appena abbozzata. Se va bene, si compone di un’email generica (“info”; “segreteria”) e poche o assenti indicazioni su chi contattare, management e responsabilità. Nei peggiori casi, si troverà un anonimo form o il numero di telefono di un centralino. Message in the bottle…
Telefonare per informazioni su un lavoro
all’estero
È perfettamente normale abbozzare una richiesta del genere: “buongiorno. Siccome sono interessata a quello che fate e credo di avere un profilo coerente, volevo sapere se ci sono o saranno in futuro opportunità, se il turnover del personale è alto, e nel caso, a chi si possa inviare il CV/con chi si possa parlare”. È sottointeso che così, in caso di risposta negativa, il candidato non perde tempo a inviare il CV. Al contempo, confermare la possibilità di opportunità future non è vissuto certo come un’insidia (dopotutto, ci saranno delle selezioni, no? Se non ti vogliono non ti selezionano); al contrario, ti ringraziano, perché hai dimostrato interesse nel loro business, e si sa che se le competenze si combinano con l’interesse, tu ti trasformi in un vantaggio competitivo per loro.
in Italia
La domanda di cui sopra genera nell’interlocutore un profondo imbarazzo, circa una verità imperscrutabile e insvelabile, come se gli fosse chiesto qualcosa di indiscreto e insidioso al tempo. Ingestibile. Balbettii. Voce secca e distratta: “mandi il CV all’indirizzo info, sul sito”. Alla sollecitazione su informazioni circa possibilità di allargamento future e livello di turnover del personale (cosa che peraltro avevo già verificato tramite altri canali), scatta il panico: “mi spiace ma su questo non posso dirle nulla”, come se si trattasse di un particolare strategico in grado di mettere a repentaglio la sicurezza delle proprie linee.
Scrivere un’email
all’estero
Tu scrivi. Loro ti rispondono
in Italia
Anche no.
Appellativi
all’estero
Nome e cognome. Dopo un paio di incontri, anche solo nome. Questo non mette in discussione il rispetto della gerarchia sul piano professionale, ma rappresenta l’assunzione del rispetto e della parità sul lato umano e personale.
in Italia
Sono tutti dottori e dottoresse. Non che riconoscere un titolo o un merito sia sbagliato. Ma spesso viene usato come vacuo spauracchio di potere fine a se stesso, e soprattutto – e questa è la cosa più importante – senza fare distinzione tra dimensione professionale e personale.
Chiedere un appuntamento
all’estero
Chiunque può proporre un incontro a chiunque, anche a direttori e direttori generali. L’indirizzo email è online, si scrive direttamente alla persona, ci si presenta e si chiede un appuntamento. Si riceve una risposta, anche direttamente dall’interessato, e in caso di disponibilità e reciproco interesse ci si accorda per una data. Imprevisti o annullamenti possono insorgere a ogni latitudine certo, ma prima si prende un impegno comune, interpretando l’incontro come un occasione di reciproco scambio e opportunità.
in Italia
Propostoti un incontro, ti si invita a comunicare le date di passaggio in una città per fissare col direttore – il tutto ovviamente indirettamente, tramite la segretaria. Nonostante ciò, non si fissa un giorno e un tempo in agenda. No. Si lascia tutto aperto, senza nemmeno una programmazione di massima. In caso di disponibilità, si fisserà qualche giorno prima, come se l’altro non avesse impegni di sorta e fosse sempre “a disposizione” – e soprattutto abitasse dietro l’angolo.
Perché è così che è visto il lavoratore in Italia. Una persona “a disposizione” e implicitamente ricattata, in un rapporto monodirezionale (io ti do lavoro) e gerarchico (io ho il potere, tu no).
Convinta che qualsiasi cambiamento normativo debba essere concepito in relazione al sostrato culturale in cui si innesta, e che qualsiasi virtuosa trovata super-sostenibile o super-competitiva di stampo nordico o anglosassone – quando impiantata nei suoli coloriti del mediterraneo – possa dar vita a imprevedibili teatri dell’assurdo, mi interrogo sulle variabili che possano davvero contribuire a promuovere competitività, meritocrazia e trasparenza nel mercato del lavoro italiano, nonché promuovere i giovani a posizioni di responsabilità.
E mi chiedo, quale sarebbe davvero il peso specifico dei vari interventi legislativi, riforme dei contratti e misure di supporto ai giovani, a fronte di una cultura dei misteri e non basata sulla valorizzazione delle risorse?
0.000000
0.000000
Read Full Post »